Louisville, Kentucky, 1991.
La terra dei ragni. Il dominio dei ragni. Piccoli legger esseri di antica evoluzione che si muovono silenziosi in ogni direzione, altezze, pertugi, voragini, angoli… niente è loro precluso, tessono con calma e maestria la loro tela aspettando seraficamente la preda. Una litania dell’attesa, delle distanze, dei silenzi, delle vite in formazione, della depressione latente, nelle taverne dei sobborghi borghesi poco differenti l’uno dall’altro se non per la genialità degli occupanti. Taverne piene di ragni, adolescenza e chitarre dal suono stridente e sghembo. Non siamo nel distopico contemporaneo di Harmony Korine. Siamo nella tranquillità di una tra le tante città americane, fuori dal turbinio della pubblicità e dalle influenze della moda usa e getta.
Una batteria tanto rarefatta quanto inevitabile, armoniche melanconiche e morbidamente rassegnate al ritorno dell’uguale nelle periferie metropolitane. L’eterna solitudine resa ancora più stridente dalla fine degli scintillanti anni ’80. Ma qui degli anni di plastica troviamo solo le influenze underground, di quel post-punk o meglio di quel post-hardcore in continua evoluzione che da Pink Flag dei Wire si è sfaccettato in mille modi, prendendo una deriva più melodica con esperimenti “art-pop” (vedi i Wire stessi), virando sulla no-wave, accelerando ruvido e estremamente marziale (come i Big Black), o diventando un inno al dogma Do It Yourself dei Fugazi, underground veramente indiependente. Questi ultimi iniziano la loro carriera nel 1987, anno di uscita di un caposaldo dell’evoluzione hardcore americana, Skag Heaven degli Squirrel Bait, gruppo nativo della nostra Louisville in cui troviamo un ragazzino alla chitarra, tale Brian McMahan che parteciperà un paio di anni dopo alla formazione degli Slint, insieme a Britt Walford (batteria), David Payo (chitarra), Ethan Buckler (basso).
Spiderland. Un album che è una rivoluzione, un album da “ten f***ing stars” come scrisse Steve Albini su Meody Maker:
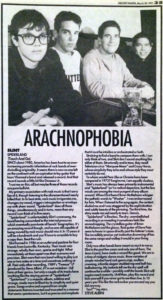
Post-punk che diventa post-postpunk in cui l’energia che emergeva stridente e albinizzata in Tweez (più assimilabile alla noise no-wave della Gioventù Sonica – come in Kent- che strizza l’occhio all’industrial -Warren- e ai Scratch Acid), ora assume una delicatezza sovversiva, una triste comprensione dell’inutilità della corsa in un campo che non lascia intravvedere meta alcuna. Ma se la fine non si intravvede, persino la direzione sembra essere in dubbio. Ma tutto questo vagare e sperimentare di quattro ragazzini ventenni ha rivoluzionato tutto il panorama della musica underground: con il suo mix di rarefazione sincopata, sussurri pesanti come macigni e chitarre stanche sebbene graffianti ha fertilizzato correnti come post-rock, slow-core, math-rock depressivo compulsivo misto ambient e tutto ciò che ancora non conosco né ho avuto il piacere di ascoltare.
Non ho ancora trovato qualcosa di altrettanto intenso e intimo come questo album degli Slint, profondo ed epocale, un album che ha fatto vibrare le armoniche tanto da essere il secondo ed ultimo lavoro dei 4 ragazzi.
Per rendersi conto di chi fossero gli Slint, la loro età e la loro storia, consiglio la visione di Breadcrumb Trail (2014), documentario di Lance Bangs, disponibile sul tubo a questo link.
… oh, I miss you!
